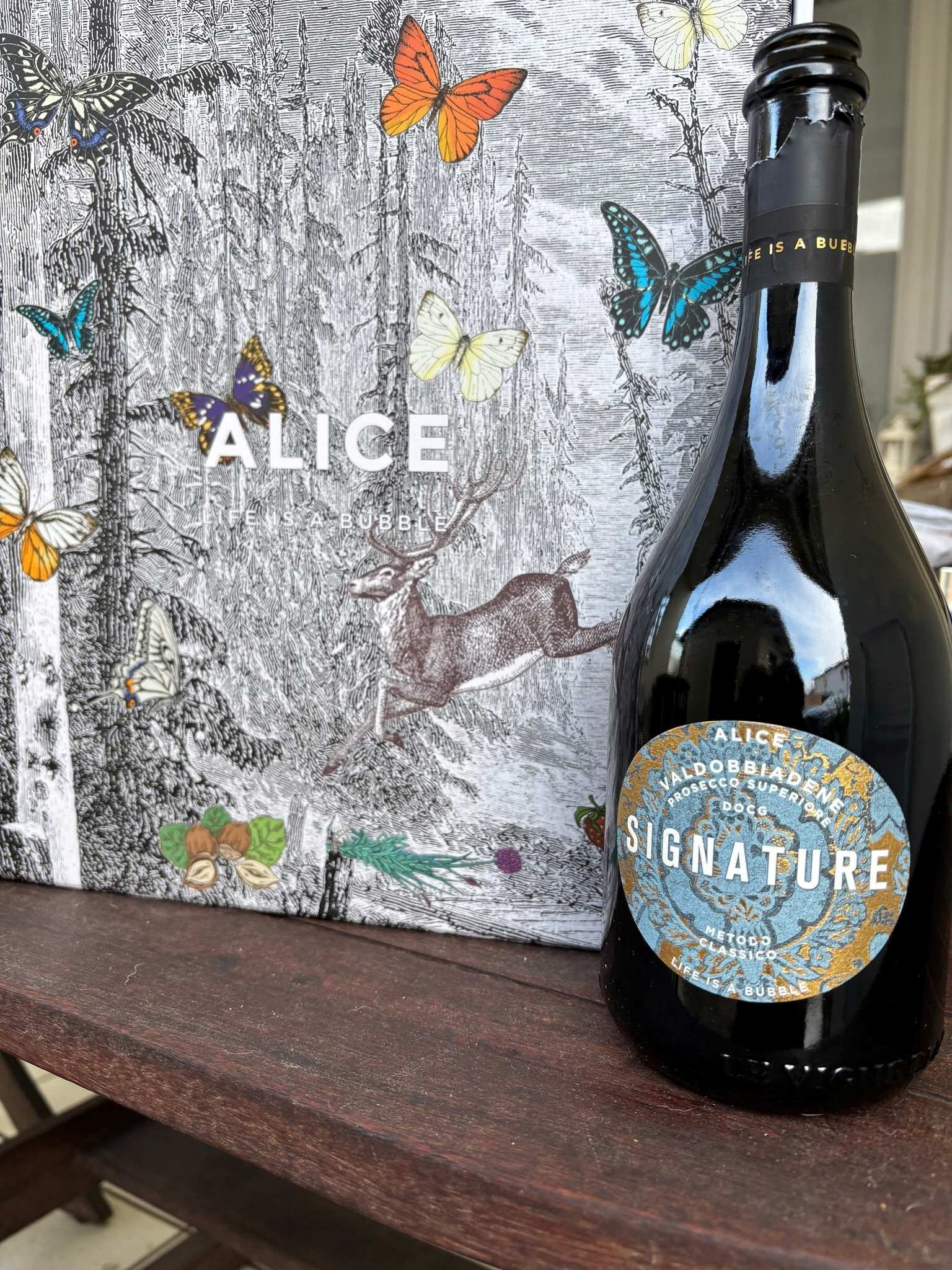L’approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, come il tipo Vialone, dal chicco grosso e relativamente più tozzo del chicco tipo Caterina, che ha forma allungata, quasi di fuso. Un riso non interamente «sbramato», cioè non interamente spogliato del pericarpo, incontra il favore degli intendenti piemontesi e lombardi, dei coltivatori diretti, per la loro privata cucina. Il chicco, a guardarlo bene, si palesa qua e là coperto dai residui sbrani d’una pellicola, il pericarpo, come da una lacera veste color noce o color cuoio, ma esilissima: cucinato a regola, dà luogo a risotti eccellenti, nutrienti, ricchi di quelle vitamine che rendono insigni i frumenti teneri, i semi, e le loro bucce velari. Il risotto alla paesana riesce da detti risi particolarmente squisito, ma anche il risotto alla milanese: un po’ più scuro, è vero, dopo l’aurato battesimo dello zafferano.
Recipiente classico per la cottura del risotto alla milanese è la casseruola rotonda, ma anche ovale, di rame stagnato, con manico di ferro: la vecchia e pesante casseruola di cui da un certo momento in poi non si sono più avute notizie: prezioso arredo della vecchia, della vasta cucina: faceva parte come numero essenziale del «rame» o dei «rami» di cucina, se un vecchio poeta, il Bussano, non ha trascurato di noverarla nei suoi poetici « interni », ove i lucidi rami più d’una volta figurano sull’ammattonato, a captare e a rimandare un raggio del sole che, digerito il pranzo, decade. Rapitoci il vecchio rame, non rimane che aver fede nel sostituto: l’alluminio.
La casseruola, tenuta al fuoco pel manico o per una presa di feltro con la sinistra mano, riceva degli spicchi o dei minimi pezzi di cipolla tenera, e un quarto di ramaiolo di brodo, preferibilmente di manzo: e burro lodigiano di classe.
Burro, quantum prodest, udito il numero de’ commensali. Al primo soffriggere di codesto modico apporto, butirroso-cipollino, per piccoli reiterati versamenti, sarà buttato il riso: a poco a poco, fino a raggiungere un totale di due tre pugni a persona, secondo l’appetito prevedibile degli attavolati: né il poco brodo vorrà dare inizio per sé solo a un processo di bollitura del riso: il mestolo (di legno, ora) ci avrà che fare tuttavia: gira e rigira. I chicchi dovranno pertanto rosolarsi e a momenti indurarsi contro il fondo stagnato, ardente, in codesta fase del rituale, mantenendo ognuno la propria «personalità»: non impastarsi e neppure aggrumarsi».
(Carlo Emilio Gadda)
La ricetta del risotto alla milanese nella versione di Carlo Emilio Gadda fu pubblicata nell’autunno del 1959 su Il Gatto Selvatico, rivista edita tra il 1955 e il 1964 dalla società ENI di Enrico Mattei. In quella spasmodica – quasi vitale, come l’aria che manca – necessità di definire con precisione assoluta la realtà ultima delle cose, si riconosce tutta la personalità artistica di Gadda.
L’ottimismo strutturalista di molti suoi coetanei si schianta, con lui, contro un crollo catastrofico. Eppure Gadda, pur segnato profondamente dall’esperienza della Grande Guerra, non si rifugia nell’ermetismo né fonda la sua poetica sulla sfiducia nella parola. Al contrario: è proprio la sua incontenibile logorrea a diventare una dichiarazione d’intenti.
Nel tentativo di descrivere ogni cosa con chiarezza quasi dolorosa, Gadda mette in dialogo la sua mente tecnica, formata da ingegnere, con uno spirito artistico legato – con piglio severo – alle dinamiche decadenti. Per questo è prima di tutto un post-romantico: per l’ambiguità profonda che nasce dallo scontro tra la sua natura razionale e quella più oscura, istintivamente poetica.
In certi casi, come nel suo capolavoro La cognizione del dolore, questa tensione si spinge fino a un surrealismo torturante. In questa ricetta, invece, decisamente più accessibile, emerge una vena ironica, una parodia dei morigerati manuali per casalinghe borghesi – che, sia chiaro, chi scrive ama alla follia (il Talismano della felicità di Ada Boni su tutti). Ma è un’ironia graffiante, venata di malinconia.
Dentro questo testo solo apparentemente innocuo, c’è tutta la poetica ambigua di Gadda: l’oscillazione tra linguaggio tecnico e approssimazione lirica, l’ironia pungente, il sarcasmo satirico ma partecipe, e – perché no – una malinconia crepuscolare. Una nostalgia quasi infantile per un mondo ordinato, borghese, che l’artista disprezza per la sua compiaciuta superficialità, ma che l’uomo non può fare a meno di riconoscere come parte del proprio universo.
the image of the rice, originally posted to Flickr, was reviewed on 29 May 2009 by the administrator or reviewer Juliancolton, who confirmed that it was available on Flickr under the stated license on that date.