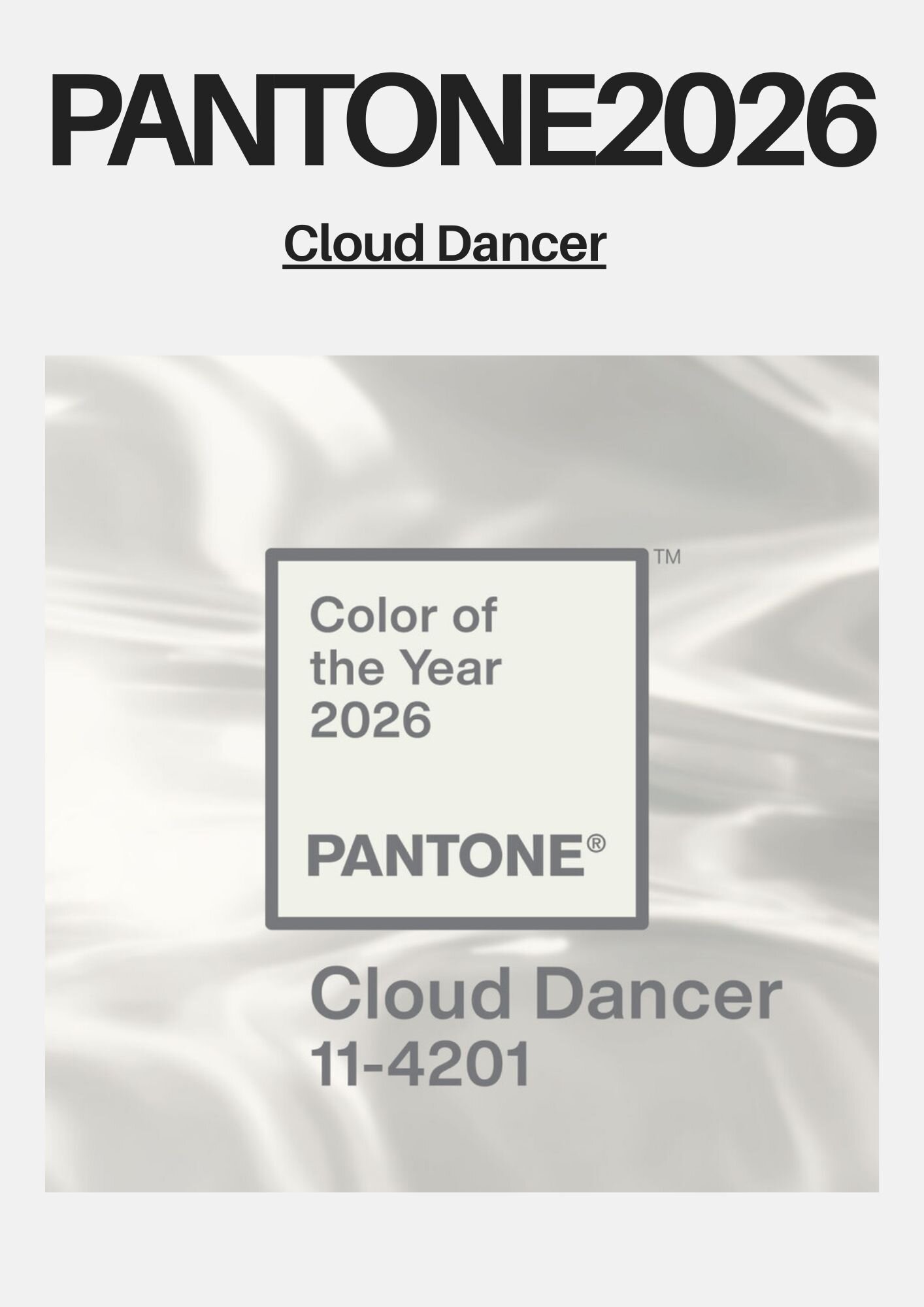_-_janet_ågren_and_ugo_pagliai.jpeg)
Negli anni ’70 del secolo scorso, in un Paese dove l’analfabetismo era ancora diffuso e l’accesso ai grandi racconti della letteratura, del mito e della storia non era scontato, la RAI si fece carico di una funzione educativa profonda. A testimoniarlo non è solo l’accuratezza delle sceneggiature, la qualità della recitazione o il rigore delle ricostruzioni: basti pensare a Odissea (1968), dove a introdurre la narrazione è la voce di Giuseppe Ungaretti, tra le rovine dell’antica Troia. Un poeta, un classico, un archetipo del viaggio umano: tutto questo in prima serata, sulla televisione di Stato.
Un monopolio virtuoso
In quegli anni, con soli due canali disponibili e senza alternative private, la televisione pubblica era parte integrante della vita quotidiana. Non c’era scelta, ma forse proprio per questo il servizio pubblico si sentiva investito di una responsabilità: educare, formare, elevare. Gli sceneggiati, che oggi chiameremmo “serie tv”, erano tra gli strumenti principali per portare la cultura nelle case. Non si trattava di un’operazione elitaria: le opere proposte erano pensate per essere accessibili, ma mai banalizzate.
Produzioni come I Promessi Sposi di Sandro Bolchi, Il mulino del Po, Marco Visconti, La cittadella o L’amaro caso della Baronessa di Carini riuscivano a fondere intrattenimento e letteratura, a creare comunità attorno al racconto, a dare un volto alle parole dei libri. E lo facevano con attori formidabili, registi attenti e una sceneggiatura che non aveva paura della complessità.
Il fantastico colto: quando il mistero educa
Accanto agli adattamenti letterari e alle narrazioni storiche, una delle tendenze più sorprendenti della televisione italiana degli anni ’70 fu l’apertura a un immaginario fantastico, colto ed esoterico. Sceneggiati come A come Andromeda (1972), adattamento italiano della serie britannica, e Gamma (1975), dai temi filosofico-fantascientifici come il trapianto di cervello e l’identità, affrontavano interrogativi esistenziali e scientifici profondi, pur mantenendo un alto livello di tensione narrativa.
Tra i fenomeni di costume indimenticabili, Il segno del comando (1971) restò impresso nell’immaginario collettivo: inchiodò alla tv milioni di spettatori e turbò le loro notti con una Roma notturna e metafisica. È un'opera emblematica del “fantastico colto”. Qui la regia è di Daniele D’Anza, considerato uno dei maestri del genere, in grado di fondere esoterismo, arte e letteratura in un racconto ipnotico. Con ESP (1973), L’amaro caso della Baronessa di Carini (1975) e altri titoli, D’Anza portò alla televisione storie sospese tra realtà e mistero, arricchite da una rigorosa analisi narrativa.
Un’educazione attraverso l’immaginario
Questi sceneggiati non si limitavano a trasmettere contenuti: insegnavano un modo di guardare, di ascoltare, di pensare. Erano lenti, nel senso più alto del termine. Concedevano spazio alla parola, al silenzio, all’inquadratura che suggerisce piuttosto che spiegare. In un’epoca che aveva ancora tempo, la televisione sapeva cosa farne.
Lontani anni luce dalla tv urlata che prenderà piede negli anni ’80 con la liberalizzazione dell’etere, questi prodotti avevano una forza quasi pedagogica. Non moralistica, non imposta, ma profondamente formativa. Perché trattavano lo spettatore come una persona intelligente, curiosa, pronta a lasciarsi coinvolgere da storie che parlavano alla mente e allo spirito.
Una memoria da custodire (e da rivedere)
Molti di questi sceneggiati oggi si trovano negli archivi RAI o su piattaforme dedicate. Rivederli non è solo un esercizio nostalgico, ma un atto di riconoscenza verso una stagione in cui la cultura passava per i canali ufficiali, e lo faceva con serietà e grazia. Di seguito una selezione ragionata dei titoli da recuperare: una piccola guida sentimentale e culturale per chi vuole riscoprire la grande stagione della televisione educativa italiana.
Classici letterari e storici
I promessi sposi (1967) – Regia di Sandro Bolchi
Un capolavoro assoluto della televisione italiana, con Nino Castelnuovo e Paola Pitagora. Rigoroso, elegante, fedele al romanzo manzoniano, rappresenta un momento fondativo della tv educativa.
Odissea (1968) – Regia di Franco Rossi
Un’opera monumentale, tra i primi grandi sceneggiati europei. Girato tra Grecia e Tunisia, con Bekim Fehmiu nei panni di Ulisse. La voce narrante di Giuseppe Ungaretti conferisce un’aura poetica senza tempo.
L’amaro caso della Baronessa di Carini (1975) – Regia di Daniele D’Anza
Rievocazione storica con elementi gotici, tratta da una leggenda siciliana. Un cult popolare tra mistero e vendetta.
Sandokan (1976) – Regia di Sergio Sollima
Tratto dai romanzi di Emilio Salgari, con Kabir Bedi nel ruolo del pirata malese, è stato un vero e proprio successo popolare. Avventura, romanticismo e lotta per la libertà, con un’impronta epica e coinvolgente.
Fantastico, esoterico e fantascienza
Il segno del comando (1971) – Regia di Daniele D’Anza
Il capolavoro del mistero all’italiana. Roma diventa una città metafisica, il tempo si spezza, l’identità vacilla. Indimenticabile la figura enigmatica di Lucia.
A come Andromeda (1972) – Regia di Vittorio Cottafavi
Fantascienza raffinata, remake di una serie BBC. Una trasmissione aliena viene decodificata: nasce una creatura. Suspense e filosofia.
ESP (1973) – Regia di Daniele D’Anza
Ispirato al sensitivo olandese Gerard Croiset. Un’indagine elegante sull’invisibile, tra scienza e parapsicologia.
Gamma (1975) – Regia di Salvatore Nocita
Trapianto di cervello, identità, libero arbitrio: un medical sci-fi teso, sofisticato, visionario. Con Giulio Brogi e Laura Belli.
Ritratto di donna velata (1975) – Regia di Flaminio Bollini
Con Daria Nicolodi e Nino Castelnuovo. Un raffinato racconto gotico ambientato a Firenze, tra arte, apparizioni e presenze inquietanti. Suspense, eleganza e ambiguità. Da recuperare assolutamente.
Giallo, noir, tensione psicologica
Coralba (1970) – Regia di Daniele D’Anza
Giallo sofisticato con Rossella Falk. La scomparsa di una donna si trasforma in indagine sull’identità e sulla memoria.
Dov’è Anna? (1976) – Regia di Piero Schivazappa
Con Mariangela Melato. Un’indagine personale e sociale. Diventò un caso mediatico per il suo finale “aperto” e la partecipazione del pubblico.
Il fauno di marmo (1977) – Regia di Silverio Blasi
Dall’omonimo romanzo di Hawthorne. Un thriller psicologico ambientato nella Roma ottocentesca, tra statue antiche e senso di colpa.
Racconti fantastici (1979) – Regia di Daniele D’Anza
Serie antologica ispirata liberamente ai racconti di Edgar Allan Poe, crepuscolare e spettrale. Con atmosfere gotiche e scenografie di grande suggestione, è un omaggio colto e raffinato al mistero letterario. La colonna sonora originale dei Pooh, rarefatta e ipnotica, amplifica l’effetto perturbante e contribuisce a rendere ogni episodio un piccolo film d'autore.
There was a time when Italian television had a cultural mission.
In the 1970s, in a country where illiteracy was still widespread and access to the great stories of literature, myth, and history was far from guaranteed, RAI took on a deep educational role. This wasn’t just evident in the quality of the scripts, the acting, or the historical accuracy of the productions—it was a true calling. Just think of Odissea (1968), introduced by the voice of Giuseppe Ungaretti, standing among the ruins of ancient Troy. A poet, a classic, an archetype of the human journey—all this aired during prime time on public television.
A virtuous monopoly
Back then, with only two available channels and no private alternatives, public television was an integral part of daily life. There was no real choice, and perhaps precisely because of that, public broadcasting felt a responsibility: to educate, to shape, to elevate. What we now call “TV series” were known as sceneggiati, and they were a key tool for bringing culture into people’s homes. These productions were not elitist: they were designed to be accessible, but never dumbed down.
Series like I Promessi Sposi by Sandro Bolchi, Il mulino del Po, Marco Visconti, La cittadella, or L’amaro caso della Baronessa di Carini managed to blend entertainment and literature, to build communities around stories, to give faces to the words of books. They did so with remarkable actors, meticulous directors, and scripts that weren’t afraid of complexity.
Intellectual fantasy: when mystery becomes education
Alongside literary adaptations and historical narratives, one of the most surprising trends of Italian television in the 1970s was its embrace of a refined, intellectual, and even esoteric form of fantasy. Series like A come Andromeda (1972), the Italian adaptation of a British show, and Gamma (1975), which explored philosophical and sci-fi themes such as brain transplants and identity, tackled deep existential and scientific questions while maintaining gripping plotlines.
Among the unforgettable cultural phenomena of the time, Il segno del comando (1971) left a lasting impression on the collective imagination. It kept millions glued to their screens and haunted their dreams with its metaphysical, nocturnal vision of Rome. This is a quintessential example of fantastico colto—cultured fantasy. Directed by Daniele D’Anza, considered a master of the genre, the series seamlessly wove together esotericism, art, and literature in a hypnotic narrative. With other titles like ESP (1973) and L’amaro caso della Baronessa di Carini (1975), D’Anza brought to television stories suspended between reality and mystery, enriched by careful narrative analysis.
An education through imagination
These series didn’t just convey content—they taught a way of seeing, listening, and thinking. They were slow, in the highest sense of the word. They gave space to words, to silence, to shots that suggest rather than explain. In a time when people still had time, television knew how to use it.
Light years away from the shouty, fast-paced TV that would take hold in the 1980s with the liberalization of the airwaves, these productions had an almost pedagogical power. Not moralistic, not imposed, but deeply formative. Because they treated the viewer as an intelligent, curious person, ready to be drawn into stories that spoke to both the mind and the spirit.
A memory to preserve (and revisit)
Many of these series can now be found in RAI archives or on dedicated platforms. Watching them again is not just an act of nostalgia—it’s an expression of gratitude for a time when culture flowed through official channels, and did so with seriousness and grace.
Below is a curated selection of titles worth rediscovering: a small sentimental and cultural guide for anyone who wants to reconnect with the golden age of educational Italian television.
Photo credits
Pizzaebirra2008 at the Italian Wikipedia project., Public domain, via Wikimedia Commons