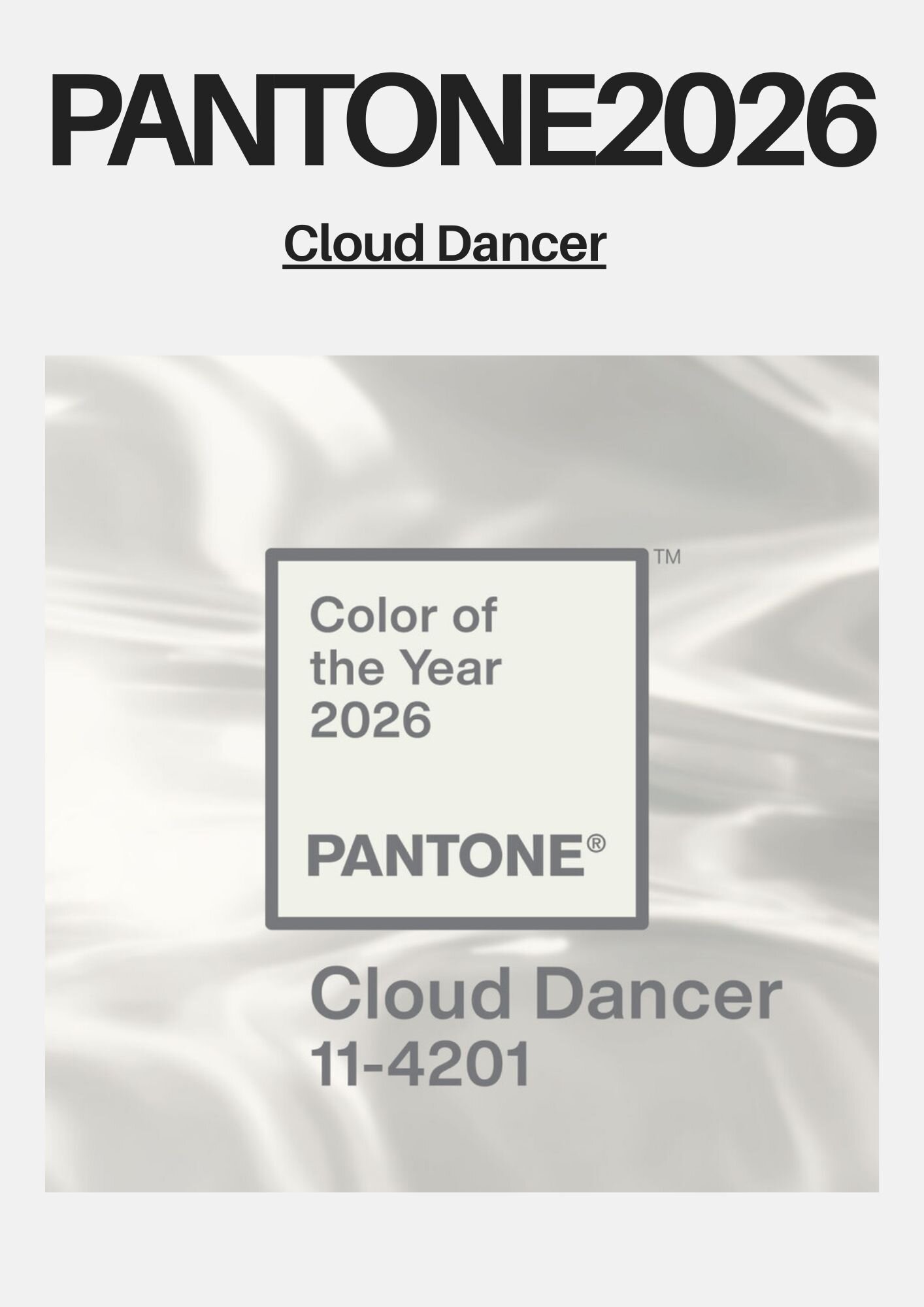.png)
C’è un pezzo di cinema italiano che abbiamo voluto dimenticare. Un genere considerato minore, eppure capace come pochi altri di raccontare a modo suo un’Italia tesa, violenta, piena di contraddizioni.
È il poliziottesco: cinema popolare, riottoso, scomodo. E, proprio per questo, autentico.
Per anni relegato ai margini della Storia del Cinema, il poliziottesco è stato accusato di tutto: qualunquismo, reazionarismo, povertà narrativa, moralismo di bassa lega. La critica lo ha snobbato, con pochissime eccezioni.
Eppure, oggi, rivedendo quei film, ci accorgiamo che sotto la patina di inseguimenti, sparatorie e commissari maneschi, c’era spesso un Paese che faceva i conti con le proprie paure più profonde.
Un genere emarginato, ma influente
Nato nella seconda metà degli anni Sessanta e fiorito per circa un decennio, il poliziottesco ha assorbito l’energia del tempo: gli Anni di Piombo, il terrorismo urbano, la Strategia della tensione, la corruzione politica.
Un cinema che si alimentava di cronaca nera e inquietudini reali, restituite con un linguaggio ruvido e diretto. Altro che fiction rassicuranti: qui si raccontava la città come teatro di una guerra quotidiana tra giustizia e violenza.
Non a caso, lo stesso Quentin Tarantino ha più volte dichiarato il suo debito verso il poliziottesco italiano, citandolo esplicitamente nei suoi film, da Le Iene a Pulp Fiction. E proprio lui, nel 2004, portò alla Mostra del Cinema di Venezia una retrospettiva dedicata a Fernando Di Leo, regista simbolo del filone.
Fu un momento simbolico: il cinema reietto veniva finalmente accolto nel tempio dell’autorialità.
Il Paese reale, senza filtri
A differenza del cinema politico impegnato (quello di Rosi o Petri, per intenderci), il poliziottesco parlava una lingua più sporca, meno raffinata ma forse più istintiva. Denunciava storture vere: una giustizia inefficace, lo scollamento tra Stato e cittadini, la delinquenza che dilagava nell’indifferenza.
Damiano Damiani fu uno dei pochi a tenere insieme tensione civile e struttura da film d’azione. Ma più spesso i registi del poliziottesco (Umberto Lenzi, Stelvio Massi, Enzo G. Castellari, Ruggero Deodato) preferivano storie brutali, rese con uno stile nervoso, a tratti documentaristico.
Erano film tecnicamente disomogenei, certo, ma colpivano allo stomaco. Popolati da figure memorabili: commissari in lotta contro tutti (Luc Merenda, Franco Nero, Enrico Maria Salerno, Maurizio Merli, Franco Gasparri), criminali senza redenzione, città in fiamme.
E poi Tomas Milian, l’attore cubano che diventò l’icona assoluta del genere. Prima nei ruoli drammatici, poi nei panni grotteschi di Nico Giraldi, tra poliziesco e commedia trash.
Una trasformazione che segnò anche la deriva finale del filone, sempre più ibridato, fino alla parodia involontaria.
La fine e la sopravvivenza
Con l’arrivo degli anni ’80, il poliziottesco perse slancio. L’industria cinematografica era in crisi, le tv private cambiavano il mercato, e la realtà da raccontare era ormai troppo complessa per le vecchie formule.
I commissari si spostarono in provincia o all’estero, le storie diventarono più confuse, i budget si ridussero drasticamente.
Il genere sopravvisse per un po’ in televisione, trasformandosi in fiction beneducate, popolate da commissari gentili e rassicuranti.
Ma il poliziottesco autentico, quello crudo e sporco, finì per diventare oggetto di culto.
Riscoperto, rivalutato, analizzato. A volte ancora deriso. Ma mai più ignorato.
Un cinema da riscoprire
Per molto tempo, il poliziottesco è stato relegato al ruolo di cinema di serie B, guardato con sospetto o con ironia, raramente preso sul serio. Ma oggi, rivedendo quei film, è più chiaro quanto fossero capaci di cogliere le tensioni profonde del Paese, spesso con uno sguardo più lucido e meno filtrato di tanto cinema "alto".
Non era necessario scegliere tra autorialità e genere: anche nelle produzioni più popolari si trovano visioni potenti, personaggi memorabili, un senso drammatico del presente.
Tra tutti, Fernando Di Leo resta la figura centrale: regista visionario e narratore impietoso, ha saputo trasformare storie criminali in radiografie sociali. Film come Milano calibro 9 o La mala ordina sono oggi riconosciuti come capolavori del cinema di genere.
Una dimostrazione che il poliziottesco, quando aveva un’anima e una direzione, sapeva arrivare ben oltre l’intrattenimento.
11 titoli fondamentali del poliziottesco italiano
- Milano calibro 9 (1972) – Fernando Di Leo
Capolavoro assoluto del genere: eleganza visiva, noir urbano, sceneggiatura perfetta. - La polizia accusa: il Servizio Segreto uccide (1975) – Sergio Martino
Thriller politico-giudiziario teso e lucido, tra i più raffinati nella critica al potere. - Roma a mano armata (1976) – Umberto Lenzi
Crudissimo, dinamico, con un Tomas Milian da antologia. Icona della deriva giustizialista. - Liberi armati pericolosi (1976) – Romolo Guerrieri
Un film atipico ma potentissimo: l’idea della violenza come gesto gratuito, giovanile, quasi privo di razionalità sociale o ideologica, è profetica. - Il boss (1973) – Fernando Di Leo
Ferocemente antimafioso, terzo capitolo della "trilogia del milieu". Grottesco e brutale. - La polizia ringrazia (1972) – Stefano Vanzina (Steno)
Tra i più sottili e ambigui: polizia e legge visti in chiave inquietante e moderna. - Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica (1971) – Damiano Damiani
Vertice del filone più civile: la legge contro sé stessa. - Cani arrabbiati (1974) – Mario Bava
Non è un poliziottesco in senso stretto, ma è un capolavoro di tensione e claustrofobia. Mario Bava lo gira come un film da camera dentro un’auto, e riesce a costruire un’opera secca, violenta, quasi kafkiana. L’influenza sul cinema successivo (Tarantino compreso) è enorme. - Il grande racket (1976) – Enzo G. Castellari
Estetica pulp e denuncia sociale, con un finale che sembra Tarantino ante litteram. - Il cinico, l’infame, il violento (1977) – Umberto Lenzi
Puro cinema di tensione e ambiguità morale. - Italia: ultimo atto? (1977) – Massimo Pirri
Un film inquietante, cupissimo, a metà tra poliziottesco e fantapolitica. Tre militanti di sinistra pianificano l’attentato a un ministro dell’Interno: ne scaturisce un colpo di stato e l’instaurazione di una dittatura militare. Profetico, viscerale, scomodo. Uscì pochi mesi prima del rapimento Moro.
Questa lista non esaurisce certo la complessità del poliziottesco, ma prova a restituirne la forza grezza, la tensione politica, l’impatto culturale. Un cinema figlio del suo tempo, che oggi ci parla ancora con una voce ruvida, sincera, necessaria.
Poliziottesco: Cinema of Lead
There’s a part of Italian cinema we’ve tried to forget. A genre long considered second-rate, yet one that—like few others—captured, in its own raw way, an Italy on edge: violent, tense, and full of contradictions.
This is poliziottesco: gritty, rebellious, uncomfortable popular cinema. And precisely for those reasons—authentic.
Pushed to the margins of film history for decades, poliziottesco was blamed for everything: political indifference, reactionary stances, shallow storytelling, lowbrow moralizing. Critics largely ignored it, with very few exceptions.
And yet, watching those films today, we realize that beneath the surface of car chases, shootouts, and tough-guy inspectors, there often lay a country grappling with its deepest fears.
A sidelined, yet influential genre
Born in the late 1960s and thriving for about a decade, poliziottesco absorbed the energy of its time: the Years of Lead, urban terrorism, the Strategy of Tension, political corruption.
It was a cinema fueled by true crime and real anxieties, delivered through a raw and direct language.
Far from being comforting fiction, it portrayed the city as a battleground in a daily war between justice and violence.
Unsurprisingly, Quentin Tarantino has often cited his debt to the Italian poliziottesco, referencing it explicitly in films like Reservoir Dogs and Pulp Fiction. In 2004, he even brought a retrospective on Fernando Di Leo—a defining director of the genre—to the Venice Film Festival.
It was a symbolic moment: the outcast cinema was finally welcomed into the temple of auteur film.
The unfiltered real country
Unlike the more overtly political films of the time (think Rosi or Petri), poliziottesco spoke a rougher language—less refined, perhaps, but more instinctive. It denounced real distortions: an ineffective justice system, a growing gap between state and citizen, a crime wave met with public indifference.
Damiano Damiani was one of the few who managed to blend social tension with action-movie structure. But more often, directors like Umberto Lenzi, Stelvio Massi, Enzo G. Castellari, and Ruggero Deodato leaned into brutal stories, delivered with a nervous, almost documentary-like style.
These films were technically uneven, yes—but they hit hard. Populated by unforgettable figures: rogue inspectors fighting everyone (Luc Merenda, Franco Nero, Enrico Maria Salerno, Maurizio Merli, Franco Gasparri), irredeemable criminals, cities in flames.
And then there was Tomas Milian, the Cuban actor who became the ultimate icon of the genre. First in dramatic roles, later as the grotesque Nico Giraldi, somewhere between crime flick and trashy comedy.
That shift also marked the genre’s decline, increasingly hybridized and eventually sliding into self-parody.
The end—and the survival
By the 1980s, poliziottesco had lost momentum. The film industry was in crisis, private television was reshaping the market, and reality had become too complex for the old formulas.
The inspectors moved to small towns or abroad, the stories grew muddled, and budgets shrank dramatically.
The genre survived for a while on TV, morphing into polite, well-behaved crime dramas starring friendly, reassuring officers.
But the true poliziottesco—raw and unfiltered—became a cult object.
Rediscovered, reappraised, studied. Sometimes still mocked. But never again ignored.
A cinema worth rediscovering
For a long time, poliziottesco was relegated to the B-movie bin—viewed with suspicion or irony, rarely taken seriously. But today, rewatching those films, it’s clear how sharply they captured the country’s deepest tensions, often with a clarity and lack of filter that so-called "high" cinema couldn’t match.
There was no need to choose between auteur and genre: even in its most popular incarnations, this cinema delivered powerful visions, memorable characters, and a raw sense of the present.
Above all, Fernando Di Leo remains the genre’s central figure: a visionary director and ruthless storyteller, capable of turning crime stories into social X-rays. Films like Milano Calibro 9 or The Italian Connection are now widely recognized as masterpieces of genre cinema.
Proof that when poliziottesco had both soul and direction, it could go far beyond mere entertainment.
Photo credits
Fernando Di Leo / Franco Villa, Public domain, via Wikimedia Commons (Luc Merenda)
The original uploader was El Tarantiniese at Italian Wikipedia., Public domain, via Wikimedia Commons (Gastone Moschin)